Io sono un mediano
Memorie di un (ex) randellatore
Nicola Chinellato
“Una vita da mediano
lavorando come Oriali
anni di fatica e botte e vinci casomai i mondiali”
L. Ligabue, Una vita da mediano in Miss Mondo,1999.
Ho iniziato ad amare il calcio fin dalla tenera età di quattro o cinque anni, nemmeno il tempo, insomma, di affacciarmi alla soglia del 1970. Una passione, la mia, dovuta, ne sono profondamente convinto, a una predisposizione genetica ereditata dal nonno materno, che sul finire degli anni venti del XX secolo aveva militato in serie A, nelle file della mitica Pro Patria. Lo chiamavano il motorino biondo, per via dei capelli chiari e di un’inesauribile propensione alla corsa che lo rendeva imprendibile anche ai più arcigni difensori avversari. Mezzala, ma talvolta anche esterno di centrocampo, ciuffo ribelle, dribbling secco e gamba robusta, il nonno si ritirò ancora giovane, a causa di un grave incidente al costato, solo poco prima di firmare un regale contratto per la Juventus. Circostanza che, nonostante il dispiacere per una carriera prematuramente interrotta, ho sempre pensato fosse un sorta di anticipato tributo d’affetto verso il nipotino, che tempo dopo sarebbe divenuto interista e acerrimo rivale sportivo dei bianconeri. Fu lui a presentarmi il pallone, il rettangolo verde, le scarpette chiodate e le gradinate dello stadio. Era lui, il mio bellissimo nonno, sciupafemmine e comunista, che mi teneva sulle gambe quando, piccolissimo, guardavo le mie prime partite di calcio nel televisore in bianco e nero della sala. Seduto come un pascià sulle sue cosce muscolose, un braccio intorno al collo e l’altro infilato in un pacchetto di patatine, ricordo come fosse oggi il profumo del suo dopobarba e il tono paziente con cui arginava un inesauribile fiume di domande.
E ricordo anche come la sua partecipazione allo svolgimento delle trame di gioco fosse improntata a un serafico aplomb, che prevedeva come acme del disappunto un fugace inarcamento del sopracciglio o una leggera increspatura all’angolo della bocca. Non mi capacitavo insomma né dei toni pacati né della totale assenza di strepiti e di imprecazioni. Perché non alzava mai un braccio nel più classico dei gesti che mimano il vaffa? Perché non pestava i pugni o si strappava i capelli come facevano tutti gli altri? Così, ogni tanto, per cercare di fugare i miei amletici dubbi, gli chiedevo per quale delle due squadre tifasse (inconcepibile per me non schierarsi), e lui mi rispondeva sempre, con salomonico ritegno: «Per quella che gioca il calcio più divertente.» Ero troppo piccolo per riflettere sulla cosa: a me piaceva veder rotolare la palla, e non capivo una ceppa di triangolazioni, sovrapposizioni, assist e funamboliche rabone. Quindi, incassavo la frase come un’oscura, ma ineffabile verità, e mi limitavo a fissare a bocca aperta quel pallone bianco a scacchi neri, che di lì a breve sarebbe diventato, insieme alla musica, il compagno di avventure della mia vita. Finché il pallone rotolava, io ero contento e mi divertivo, e tanto mi bastava. Ancora non avevo la squadra del cuore, dal momento che in famiglia, a parte mio nonno, nessuno si interessava di sport, e mio padre, che al massimo si dichiarava tiepidamente “simpatizzante del Torino”, ostentava una sprezzante antipatia per chiunque fosse tifoso di calcio. Fu lui, tuttavia, seppur in modo involontario, che riuscì a far nascere in me la passione per l’Inter e, per quanto mi riguarda, questa è stata la cosa migliore che abbia mai fatto nella sua vita.
Ricordo che era una domenica pomeriggio e la Rai passava un tempo della partita più importante della giornata, il derby della Madonnina. D’istinto, e per quello che si poteva cogliere dalle immagini che passavano disturbate sullo schermo del televisore in bianco e nero risalente al dopoguerra, mi schierai subito per la squadra che mi sembrava indossare la casacca più bella (quella coi colori neroazzurri, per intenderci). La Beneamata però iniziò a prendere un goal via l’altro (perdemmo di brutto, quella volta), e io cambiai immediatamente barricata, schierandomi in favore del Milan (questo è “coming out, baby!”). Quando lo spiegai a mio padre, che stranamente si era interessato ai miei movimenti, mi assestò uno scappellotto in testa e mi apostrofò col termine, per me allora incomprensibile, di “voltagabbana”. Non capivo cosa volesse dire, ma suonava malissimo, tanto che da quel momento in poi iniziai una carriera da interista sfegatato, non fosse altro che per evitare ulteriori randellate sul coppino. Nel frattempo, cominciai a tirare i primi calci al pallone nel campetto davanti a casa: partite esagerate, dalla durata media di tre ore, due felpe a fare i pali della porta e il portiere volante a dare un tocco di imprevedibilità all’agone. Se ero abbastanza veloce a dirlo prima degli altri, io facevo Facchetti (ciao Cipe, ti voglio bene!) e non c’era verso di farmi cambiare idea, anche se, di solito, finivo per giocare di punta (il più grande equivoco calcistico della mia vita iniziò a perseguitarmi fin dalla tenera età). Così, tornato da scuola, dopo essermi nutrito con un rapido pasto e aver fatto i compiti ancora più rapidamente, scendevo al campetto a giocare, vestendo con sommo orgoglio la mia maglietta nerazzurra numero 3, calzando un paio di fantastiche scarpette “Tepa Sport” nere con la banda bianca e tenendo sotto il braccio il mitico Tele (un pallonaccio che volava a ogni scorreggia di vento, e che quindi veniva messo dietro la porta, per essere utilizzato solo nel caso in cui il pallone di cuoio andasse perduto o bucato). La prima vera squadra in cui militai fu però quella dell’Oratorio di via Soderini, a due passi da casa. L’allenatore dei Pulcini mi aveva per caso visto giocare al solito campetto e mi volle a tutti i costi in rosa. Con il benestare dei miei genitori, accettai la proposta e così mi ritrovai con una scintillante casacca gialloverde a vestire (di nuovo) i panni dell’attaccante (perché tutti pensassero che fossi una punta, Dio solo lo sa). Siccome non era il mio ruolo, feci un solo goal in quindici partite: una leppa al volo sotto l’incrocio, così bella e precisa che ancora oggi faccio fatica ad attribuirmene la paternità.
Un solo goal per un centravanti è un po’ pochino, lo so. Il fatto è che io non ero un centravanti (non lo sono mai stato) e, anche se molti dei miei allenatori erano intimamente convinti che fosse il mio destino, io desideravo giocare più dietro, a centrocampo. D’altra parte, nel calcio esistono due tipi di giocatori: quelli che hanno un ruolo e quelli che se ne ritagliano uno. Niente di male ad adattarsi, per carità. Tuttavia, io conoscevo già il mio ruolo in campo, lo sentivo nelle gambe e nel sangue, lo capivo da come intuivo i movimenti della palla e da come correvo senza requie fino a bruciarmi i polmoni. Io ero un mediano, lo sono sempre stato. Non ho mai avuto i piedi buoni, né tanto meno il fiuto del goal. Sono sempre stato troppo emotivo per dare la schiena alla porta e trovare l’attimo giusto per girarmi e insaccare. E poi, ho sempre pensato che dare la schiena alla porta fosse un po’ come voltare le spalle al mondo e vivere di espedienti: correte voi che non dovete finalizzare, io invece sto qui, pronto ad approfittare dell’occasione giusta per rubare un po’ di immeritata gloria. Insomma, per fare la punta, lo dico con rispetto e ammirazione, ci vuole l’istinto del killer, una buona dose di cinismo e molta freddezza. Tutte doti di cui ero (e sono) completamente sprovvisto. A ogni modo, campetto o oratorio che fosse, io finivo sempre per giocare in attacco, e ben presto iniziai a capire il ruolo e ad adattarmi a movimenti che sentivo innaturali come indossare le infradito sopra un bel paio di calzettoni di spugna. Finché, un giorno, un mio allenatore più intuitivo di tutti gli altri, stufo di vedermi correre a perdifiato nel tentativo commovente, ma decisamente sterile, di segnare qualche goal, ascoltò le mie preghiere e mi mise a giocare in mediana. Da quel momento, la mia vita calcistica cambiò decisamente e cambiò in meglio, poiché non solo mi sentivo soddisfatto e realizzato, ma iniziai a essere considerato una pedina inamovibile della formazione. Meglio chiarirsi subito però prima che si ingenerino equivoci: ero tutto fuorché un giocatore di classe. Anzi, ero agli antipodi del classico centrocampista dalla testa alta, i piedi buoni e il lancio millimetrico. Io correvo come un bufalo sbronzo, rompevo le trame di gioco avversarie, facevo a sportellate come un vichingo all’assedio, picchiavo come un fabbro incattivito da problemi di acidità e mi limitavo poi a passare la palla al 10. E a proposito di randellate: a cagione di una certa esuberanza atletica e di un’interpretazione sommamente virile del ruolo, finii con il tempo per collezionare una serie di soprannomi non certo gratificanti, anche se, devo ammettere mio malgrado, decisamente azzeccati.
Il primo nomignolo me lo affibbiarono dopo un derby contro la Cascina Ferrara, compagine saronnese, contro la quale il Quartiere Santuario, squadra in cui militavo ai tempi, dava vita a stracittadine combattute con il coltello e la carogna fra i denti. Quella partita terminò, nemmeno a farlo apposta, con una mega rissa da saloon tra le tifoserie, e conseguente retata delle forze dell’ordine, intervenute per sedare i facinorosi, sempre più sul punto di ricorrere a spranghe e catene. Pioveva a dirotto, il campo era diventato un acquitrino fangoso e la rivalità piuttosto accesa fra le due compagini aveva, per così dire, esacerbato un filo gli animi. In questo contesto per niente ludico, accecato dall’ardore, con una proditoria (e peraltro assai scomposta) entrata in scivolata, riuscii nell’impresa di atterrare (rectius: abbattere) tre avversari in un colpo solo (credo che ancora oggi il record resista imbattuto a ogni latitudine del globo). L’intervento eccessivamente baldanzoso mi costò una semplice ammonizione, circostanza che fece imbestialire la tifoseria avversaria, convinta, non a torto, che l’arbitro ci fosse andato con la mano troppo leggera. Da quel giorno, venni pertanto chiamato “il chirurgo”, appellativo al quale, nel corso degli anni, ne seguirono altri, non meno lusinghieri, quali “assassino”, “zappatore”, “il bastardo” e per finire “il collezionista di ossa”. Che poi, a dire il vero, non ero nemmeno così cattivo: nella mia carriera ho preso solo tre espulsioni e tutte per fallo di reazione (quando mi sputavano, spero capiate, mi partiva l’embolo della violenza). Tuttavia, finirono per disegnarmi così, e la cosa, a dire la verità, mi dispiaceva assai, dal momento che, in cuor mio, sapevo di essere un giocatore un filo ruvido ma sostanzialmente leale.
Quello del mediano, d’altra parte, è un ruolo difficile e reietto, che vive soprattutto di contraddizioni prima che di epica. Altro che l’immagine banale e stereotipata di cavaliere senza macchia e senza paura, data da Ligabue in quella pessima canzone che, ne converrete, ha finito per deprimere un’intera categoria di onesti faticatori. Perché, diciamocelo fuori dai denti, il mediano è sostanzialmente uno sfigato, è il nerd del gruppo. Quando la squadra vince, il mediano la coppa non la alza, al massimo la lucida, e nelle foto di rito, quelle che incensano la vittoria, lo troverete sempre in seconda fila, il volto allucinato e il sorriso impallato da un braccio o una mano di qualcuno che esulta. Un mediano è il collante fisico e l’anima della squadra, è la prova, tutta muscoli e fiato, di quanto sia appropriato il termine collettivo quando gli undici si muovono per il campo. Dà le coordinate, tappa le falle, sostiene i compagni, si immola nell’estremo gesto. Eppure è solo, è il giocatore più solo di tutti. Non per indole, ma per necessità. La sofferenza lo trasfigura e lo estranea dal contesto. Un mediano dialoga con i propri pensieri di fatica, ascolta il grido disperato di polmoni esausti, si concentra su cose belle e lontane per sopportare il dolore delle botte prese, vive in un universo parallelo nel quale non esistono delizie ma la medaglia ha sempre lo stesso rovescio e le croci da portare sono infinite.
Vive nell’ombra, il mediano, è brutto a vedersi, è sbeffeggiato per i piedi grezzi, temuto per l’irruenza, accantonato nel momento in cui la gloria viene spartita. I mediani li guardi negli occhi e hanno tutti lo stesso sguardo: un lampo di generosità, il riflesso di una fiamma che balugina rapida nella pupilla, e quel velo di smarrita tristezza che affligge tutti coloro che già conoscono il proprio immutabile destino. Perché, credetemi, un mediano sarà sempre un numero 4, sul campo e così nella vita. Ormai da tempo, ho smesso di giocare e faccio l’allenatore. Un po’ per sopraggiunti limiti d’età e un po’ (molto) perché mi sono rotto, distorto e lussato tutto lo scibile osseo e legamentoso: due denti, il setto nasale, tre dita della mano, due costole, entrambe le caviglie, un ginocchio e tre o quattro articolazioni di cui non ho mai imparato il nome. Mi manca, come l’ossigeno sott’acqua, il campo da gioco, quel rettangolo verde che un tempo era di erba e oggi, spesso e volentieri, è un tappeto artificiale zeppo di bruscolini di gomma tossica. Eppure, mi consolo pensando che sto ancora in mezzo ai ragazzi, insegno quel poco di calcio che conosco, continuo a emozionarmi per il rumore dei tacchetti sul pavimento dello spogliatoio, per l’odore di sifcamina che punge le narici prima di scendere in campo e per quello ancora meno nobile del sudore nel dopo partita. Ho anche cambiato il mio modo di vedere il calcio: un tempo correvo per difendere, oggi produco alchimie tattiche per riuscire a mettere in campo tre punte e magari anche un paio di ali alte. È strano, ma da mister sono tornato la punta che tutti pensavano fossi da ragazzino. Nell’anima però non sono cambiato e la vita continuo a viverla con quel maledetto numero 4 marchiato a fuoco sulle spalle. Così, attraverso i miei giorni di corsa, costretto a lottare per conquistare metri, centimetri, spazio per respirare. La gloria se ne sta sempre voltata dall’altra parte e il successo bacia in fronte il centravanti che la butta dentro. Ma il ruolo mi piace e non lo cambierei per nulla al mondo. Amo stare in mezzo al campo, dove tutto succede e nulla è prescindibile, anche il più piccolo movimento. Se sei un mediano, in fin dei conti, correre è tutto ciò che desideri e non ci sono cazzi. Non andate però a raccontarlo alle mie giunture: temo non sarebbero d’accordo.
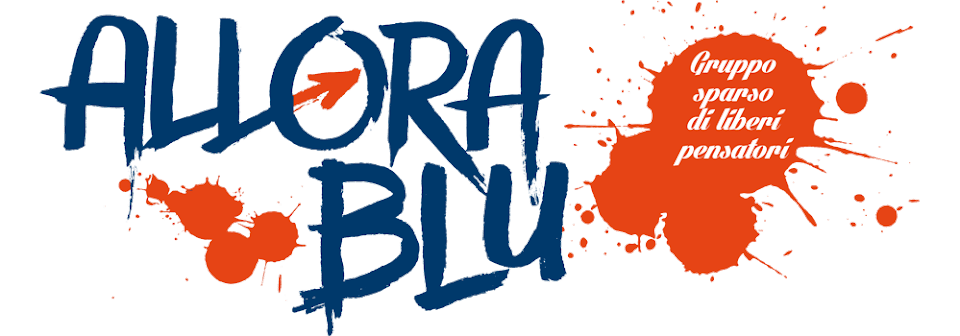

Nessun commento:
Posta un commento