(prima parte) (seconda parte) (terza parte)
Ciao Villapizzone
Il Pelanda era sbarcato da qualche giorno a Linate con un volo charter proveniente da Caracas. Si era trasferito in un paesino di fronte all’isola Margarita dove, dopo una lunga serie di disavventure imprenditoriali tra gelati e aspirapolveri, aveva cominciato a trafficare auto usate. Nel giro di qualche anno era riuscito ad avviare un fiorente commercio di Ford e Chevrolet che, non si sa come, faceva venire da Cuba. Insomma, non proprio un commendatore, ma era arrivato a comprarsi una casetta con tanto di veranda sul mare, nulla a che vedere con la stamberga presa in affitto dietro il benzinaio quand’era appena arrivato. E lì, alla fine, aveva deciso di piantar radici. Lontano anni luce dal campetto del Villapizzone.
Ciao Villapizzone
Il Pelanda era sbarcato da qualche giorno a Linate con un volo charter proveniente da Caracas. Si era trasferito in un paesino di fronte all’isola Margarita dove, dopo una lunga serie di disavventure imprenditoriali tra gelati e aspirapolveri, aveva cominciato a trafficare auto usate. Nel giro di qualche anno era riuscito ad avviare un fiorente commercio di Ford e Chevrolet che, non si sa come, faceva venire da Cuba. Insomma, non proprio un commendatore, ma era arrivato a comprarsi una casetta con tanto di veranda sul mare, nulla a che vedere con la stamberga presa in affitto dietro il benzinaio quand’era appena arrivato. E lì, alla fine, aveva deciso di piantar radici. Lontano anni luce dal campetto del Villapizzone.
Dopo una settimana la notizia dell’arrivo del Pelanda era rimasta ancora sotto traccia. Solo Zio sapeva del suo ritorno, anche perché abitava di fronte alla casa dei genitori del transfuga nel cuore della Bovisa. Ma si guardò bene dal raccontarla in giro. «Pronto? Ciao Bicio, stasera niente allenamenti, ci vediamo alle otto e mezzo alla Chiesetta per una pizza.»
«Ciao, Zio. No, guarda, stasera proprio non posso. Devo studiare, domani ho l’esame di anatomia e se mi segano anche questa volta...»
Zio non fece una piega e tirò dritto. «E allora portati i libri. Scusa, ma adesso devo scappare. Avvisi tu gli altri?»
La cornetta prese a singhiozzare e Bicio d’istinto se la portò davanti agli occhi come se volesse vedere in faccia Zio per scoprire che cosa nascondeva tutto quel suo tono misterioso. Riappese il ricevitore e buttò un occhio svogliato sulla copertina arancione del libro di testo rimasto lì sul tavolo tutto il giorno a prendere polvere. «Gli altri chi?» pensò ad alta voce.
Il tam tam lanciato dallo Zio fece il giro di tutta la squadra in un baleno. Jolly e il Rosso dovevano lavorare e, per quella sera, non se ne parlava. Pollo aveva provato a farsi scudo con la Picci, ma la scusa non reggeva. Vitellozzo aveva farfugliato qualcosa, ma aveva assicurato che sarebbe stato della banda. «Ottimo, stasera non avevo voglia di andare al Villapizzone, sotto questa pioggia poi.». Chiudere il cerchio toccò a Lillo, che già pregustava una serataccia a base di donne e bagordi. Sarebbe passato lui a prendere il Conte.
La Chiesetta era una pizzeria malconcia ai bordi della Bovisa, appisolata su una stradina stretta e buia dove non si poteva parcheggiare neanche la Vespa. Dall’altra parte era la ferrovia, che correva dietro i capannoni dismessi, a dare una parvenza di vita o solo di movimento a quell’angolo nascosto sotto il ponte della Ghisolfa. Era un posto fumoso e silenzioso, quasi come se l’aria viziata sopisse il vociare degli avventori. Le stesse facce, lo stesso menù. Correva lunga e stretta tra una fila di tavoli ricoperti da tovagliette di carta e il bancone di vetro e alluminio, ma quando veniva la bella stagione si apriva vaporosa sotto un pergolato dove le stelle giocavano a nascondino.
Piuttosto puntuale, verso le nove di sera quasi tutta la squadra si era presentata all’appello del Peroni, che si pagava l’università facendo il cameriere della Chiesetta. «Ciao ragazzi, che ci fate qui a quest’ora? Oggi niente allenamento? Volete ordinare qualcosa?»
«Ciao Peroni, aspettiamo il resto della banda,» rispose cordiale Bicio.
«A proposito, che fine ha fatto Zio? Abita qui a un tiro di schioppo!»
«E Pollo?» venne a rimorchio il Lillo.
«Sarà sotto le sottane della Picci!» bofonchiò il Conte in un abbozzo di risata grassa che invase la tavolata degli amici di squadra.
«No, sta cercando parcheggio, è mezz’ora che gira con la sua R4,» lo difese il Bicio.
«Zio non pervenuto,» sottolineò un po’ acido Vitellozzo.
«Vabbè Peroni, portaci un po’ di birre,» chiosò il Lillo per mettere tutti d’accordo.
Il primo giro di birre aveva già toccato il fondo quando Zio entrò con un ghigno trionfale nella Chiesetta, accompagnato da un altro figuro rimasto alle sue spalle. «Alla buon’ora,» lo accolse Lillo, con una punta di veleno nella voce.
«Ué ragazzi, ho una sorpresa per voi.»
Quasi simultaneamente, con una finta scartò sul lato destro per fare largo al fantasma che gli stava dietro. Tra stupore e sconcerto, un fiume di parole si accavallò sul tavolo, in uno spreco di punti esclamativi e interrogativi, come in una mischia in area di rigore.
«Non ci posso credere!»
«Minchia il Pelanda!»
«Ma tu non stavi in Sudamerica a raccogliere banane?»
«Guarda com’è ingrassato...»
«Che cazzo ci fai qui?...»
E ad ogni domanda i gomiti cercavano di conquistare centimetri verso quell’oracolo inaspettato, le voci si alzavano per sovrastare quelle precedenti, fino a quando il frastuono diventò muto. Uno scintillio brillò negli occhi del Pelanda e per una frazione di secondo illuminò gli sguardi sbigottiti dei vecchi amici.
«Va’ che bella manciata di atleti...»
Era il migliore della squadra del Villapizzone. Esuberante e gradasso sul campo, era capace di prendere la palla dalle mani del portiere e, dopo aver fatto fuori tutti gli avversari, impallinarla nella rete avversaria. Ambizioso e irascibile nella vita aveva spezzato quasi subito i garretti che i suoi genitori gli avevano infilato sui calcagni. Aveva abbandonato una brillante carriera universitaria che, sulla scia del padre, lo avrebbe proiettato nell’empireo della chimica italiana per poi farlo invecchiare tra le pareti di un laboratorio abbandonato in mezzo alla pianura per il resto della sua vita con un milione di lire al mese in tasca. Intrigante e sciupafemmine, aveva collezionato nel suo egocentrismo una dozzina di fanciulle in fiore e altrettante bagasce da quattro soldi. Per noi, pigri avventori della solita cena in famiglia, era un mito.
Naturalmente la pizza al trancio e le vicende di ognuno passarono in secondo piano davanti ai racconti, chiaramente ingigantiti, del Pelanda. Aveva una casa in riva al mare, una Chevrolet Bel Air del ‘59, una moglie mulatta e tre figli.
«Non ci credete? Allora, vi faccio vedere le foto,» disse deciso, fissando gli occhi titubanti di Lillo. Parlava con il tono di quello arrivato, ma non come un parvenu qualsiasi. Ogni sua storia era accompagnata da un sorriso ruffiano e ogni parola che gli usciva dalla bocca cercava il contatto fisico di tutti gli amici dello spogliatoio intorno al tavolo. Dall’altra parte del tavolo non poteva mancare la curiosità, che cresceva esponenzialmente ogni volta che il Pelanda apriva bocca. Dalla più molesta a quella più intrigante, lo colpivano in ogni parte del corpo facendolo sganasciare.
«Ma di’ un po’, ti siamo mancati in tutti questi anni?» buttò lì il Bicio con una risata innocua, sulla quale però Pollo ci mise il carico. «Ci pensavi ogni tanto a noi?»
Nei piatti erano rimaste solo le croste delle pizze e i boccali di birra esalavano gli ultimi vapori di malto e luppolo. Con il suo infinito silenzio, il Pelanda aveva cristallizzato l’aria della Chiesetta. Il lungo corridoio che correva di fronte al bancone si era svuotato e pareva di stare dentro il budello di una salsiccia senza carne. Sulla sua fronte correvano nel rilievo delle rughe le volate in bici, le partite a carte in cantina, le donne, le serate in birreria, le partite di pallone... Le sue labbra serrate mettevano in primo piano i muscoli della mascella e gli zigomi si contraevano come in una smorfia di affanno. Poi afferrò il boccale di birra che in un sorso evaporò. Il tonfo del bicchiere sul tavolo di legno spezzò quell’incantesimo e tutti fissarono lo sguardo sulla faccia il Pelanda. «Andiamo,» disse con un soffio spiritato. «Andiamo al Villapizzone.»
Lillo alzò il sopracciglio per esaminarlo di sbieco. Bicio e Pollo si guardarono in faccia come due che hanno nascosto il bottino. Il Conte si rollò una sigaretta e Vitellozzo abbassò la testa per farsi cadere i capelli sul viso come se volesse far calare il sipario di quella assurda pantomima. Persino Zio non sapeva più dove sbattere gli occhi: «Sei sicuro?» abbozzò con un tono di voce che pareva un avvertimento. «No ragazzi, non scherziamo, tra un po’ ho un puntello con due sbarbe ai Navigli,» irruppe categorico il Lillo. E anche Pollo cercava di togliersi dall’imbarazzo: «Muoviamoci, però, tra un po’ passa il lavaggio strade.»
Fuori dalla Chiesetta, come da tradizione, Lillo aveva acceso una canna con la quale aveva avvolto il Conte e Vitellozzo nel sogno dissoluto di una notte viziosa. Altri si defilarono, chi con la scusa dell’università, chi con quella del lavoro. Sui gradini del marciapiede davanti alla Chiesetta, Zio aveva giocato l’ultima carta. «Dai, andiamo a casa. È qui dietro l’angolo.» Il Pelanda lo fissò negli occhi duro: «Allora non hai capito?»
«Ok ragazzi, però non facciamo tardi,» disse Pollo per dare una svolta definitiva a quel capriccio.
«La macchina è vicina al cavalcavia. Vengo con voi,» si premurò di avvisare il Bicio, che mai si sarebbe perso la testimonianza diretta di una calamità.
Il vialone della Mac Mahon era scivolato via insieme al frusciare degli olmi che avevano lasciato passare indifferenti la palpitazione del Pelanda e la tachicardia degli altri. Poi la R4 di Pollo aveva inforcato la Console Marcello, un altro rettilineo da corsa ma senza alberi e senza colori, con un singhiozzo meccanico.
«Minchia ragazzi, il Villapizzone.» Era il Pelanda dei vecchi tempi, uno che si innamora dei sogni. Si puntava sullo schienale della poltrona e piantava i piedi sul cruscotto e a nulla valevano le bestemmie che tirava Pollo per tentare di sedare la furia del Pelanda, ma anche per salvare la sua R4. Bicio, seduto dietro, se ne stava muto con le mani tra i capelli e Zio al suo fianco fino all’ultimo aveva provato a spostare la traiettoria, buttando nell’abitacolo improbabili promesse di orge e di alcol.
«I miei non ci sono, possiamo andare a casa mia.»
«Sì, dopo.»
In fondo alla Console Marcello, dove una volta c’era il capolinea del 12, il Pelanda sorvolò sulle case tirate a lucido e sulla scuola bianca che era ancora lì, ma molto più moderna. Non badò neppure ai binari del tram che sterzavano a sinistra all’improvviso come per evitare un pericolo. Ma quel cavalcavia era un pugno in un occhio: pilastri che bucavano il cielo e muri di cemento che avevano inghiottito il campetto di calcio, sotterrando i ricordi epici di quattro amici che giocavano a pallone lì, al Villapizzone.
«Riportatemi a casa,» disse il Pelanda con una voce impastata dalla birra e dal magone.
«Andiamo a dormire.»
***
I quattro minuti di recupero se n’erano già andati, quando un sibilo sfrecciò vicino alla testa di Napo che riuscì solo a sfiorare quel missile terra aria indirizzato all’incrocio dei pali. Il cuoio del pallone gli spellò la fronte lasciandogli come ricordo la striscia rossa di una fiammata, ma il suo sguardo era già altrove. Con la coda dell’occhio vide il barbetta sollevarsi insieme con la palla, quasi volesse accompagnarla fisicamente lui dentro il sette. L’istante successivo Napo aveva fotografato lo sforzo plastico di Pezzey con le vene del collo che si arrampicavano verso la traversa per respingere quella palla avvelenata. Il guanto giallo di Garella si era dilatato sproporzionato nel palmo della sua mano destra che da sola riusciva a coprire la faccia di Pezzey, ma non abbastanza per raggiungere la traiettoria della palla che il barbetta vedeva già in fondo al sacco.
Come una sassata, il pallone scheggiò la traversa con un rumore sordo per poi decollare tra i platani immobili dietro la porta di Garella. La sbucciatura sulla fronte di Napo valeva una manciata di centimetri e da come si era messa la partita poteva significare tre punti in classifica. Il barbetta si era visibilmente sgonfiato. Ma il butterato e tutto il resto della Ghisolfa si avventarono come falchi addosso alla sottana del prete invocando la carità di calcio d’angolo. Con un balzo Garella si tuffò nella mischia che circondava il reverendo arbitro e insieme con la Lecca e il Banana pretendeva a muso duro il triplice fischio finale. Paonazzo e sfinito dalla fatica don Antonio ebbe un attimo di esitazione che venne riempito da una bordata di fischi. Poi con il braccio teso autorizzò il calcio d’angolo tra le proteste del pubblico di casa poco incline a mangiare la minestra fredda anche la domenica.
Che cosa significa marcare a uomo? Dentro questa domanda c’è tutto il significato maschio del gioco del calcio. E, prima o poi, tutti gli allenatori ci devono sbattere il naso tentando di dare una risposta convincente che, però, non potrà mai essere esauriente per chi si ciba di pallone dalla mattina alla sera. Una semplice domanda che nasconde tutto un mondo da scoprire o un tesoro che nessuno riuscirà mai a rubare a chi si è trovato in mezzo all’area di rigore. Sono cose che fanno crescere. La puzza e il sudore che si appiccicano nel naso e sulle mani sono solo una parte della risposta. Il resto fa parte del grande gioco della vita.
Tutta la squadra della Ghisolfa si era rovesciata in avanti e aveva invaso ogni centimetro dell’area davanti alla porta di Garella che sembrava la fermata del tram alle sette e mezzo del mattino. Un groviglio di corpi intrecciati che danzano come alberi battuti dal vento; muscoli e nervi che si avvinghiano per celebrare in un rituale tribale la forza e l’astuzia; occhi spiritati che roteano in cielo aspettando l’apparizione della palla come una profezia, mentre un filo di bava all’angolo delle bocche spalancate s’indurisce al contatto con l’aria di ghiaccio di gennaio.
Per farsi perdonare, il portiere avversario, quello scarso, si dava un gran da fare menando gomitate a destra e a manca per farsi spazio tra Mille Lire e Mezzo Litro, la Lecca aveva francobollato il butterato ai fianchi che si dimenava come un’anguilla per uscire da quell’abbraccio asfissiante; Pezzey si era piantato sulla schiena del barbetta come una scimmia per far sentire allo spilungone tutta la sua massa muscolare, le gocce del suo sudore e pure l’alito rancido che montava dal profondo delle sue budella. Napo si era abbracciato al palo per coprire il calcio d’angolo, ma anche per offrire il suo profilo da cartone animato alla Vale che era lì, a due passi dalla linea di fondo con le mani sulla bocca e lo sguardo atterrito come se fosse davanti alla scena finale di un thriller. Poteva sentire il suo profumo di lavanda ma, contro la sua volontà, non le regalò uno sguardo, nemmeno un mezzo sorriso: per mostrarle la sua concentrazione o, forse, per appagare il suo narcisismo.
Il corner aveva sorvolato tutta l’area di rigore carico di minacce. Napo si era aggrappato sul palo per vedere di incastrare quella sfera di cuoio tra i suoi riccioli, invano. La Lecca aveva abbattuto il butterato e all’ultima occasione utile era riuscito a mantenere la promessa di fargli assaggiare la lama dei suoi tacchetti. Garella si era arrampicato sulla schiena e sulle spalle della mischia umana che gli stava davanti, ma non era riuscito a smanacciare quella palla piena di veleno che volava via come una bestemmia. Il pallone cadde come un peccatore tra le braccia di don Antonio, che stava dall’altra parte della porta rispetto al calcio d’angolo. Tre fischi. Era finita.
A quell’ora l’ombra del campanile aveva tagliato in due il campetto di calcio dell’oratorio per dividere vinti e vincitori. Quelli della Ghisolfa, con la loro bella maglietta a strisce blu e gialle, avevano tentato un estremo, timido assalto alla sottana del reverendo arbitro per reclamare un calcio di rigore che, magari, in altre circostanze un vero direttore di gara avrebbe fischiato. Ma ormai anche per loro era arrivato il momento di tornare a casa con le pive nel sacco. Mazzone, il loro allenatore, li aveva richiamati a uno a uno negli spogliatoi e mentre sfilavano a testa bassa davanti alle sue gambe venivano ricompensati con un affettuoso calcio nel culo.
In mezzo all’area che fino a quel momento era stata un teatro di guerra, planò il berretto nero imbevuto di saliva e di tabacco di Nonno Garella. Da buon partigiano, non voleva perdersi l’abbraccio dei suoi ragazzi che avevano combattuto e vinto una partita di pallone. Ma forse qualcosa di più. La fine delle ostilità li aveva catturati, stremati, con un sorriso fiero e adulto. C’era chi si stringeva al petto dell’amico, chi regalava sorrisi e cazzotti che rimbombavano sulla schiena bagnata del compagno e chi si godeva la vittoria sdraiato sui sassi e sulla terra un po’ meno gelata.
Napo era rimasto lì, afflosciato intorno al palo con la sua chioma ricciuta che si perdeva tra le maglie della rete. Nella fessura degli occhi erano passate tutte le immagini di quella partita davvero incomprensibile. Dal punto di vista agonistico doveva essere una passeggiata al parchetto, invece avevano buttato sangue fino all’ultimo minuto e anche dopo. Dal punto di vista tecnico, la Ghisolfa meritava senza dubbio il terz’ultimo posto in classifica, ma quei fenomeni avevano le palle e la grinta di chi se la gioca fino in fondo a testa alta. Dal punto di vista emotivo era stata una catastrofe sul campo, eppure Napo non riusciva a togliersi dalla testa il sorriso nascosto tra le dita della Vale e l’incredibile apparizione del padre.
E se ne stava lì a rimirare quel panorama di sensazioni manco fosse una di quelle giornate di maggio che, sdraiato tra i profumi dell’erba appena tagliata, ti invitano a perderti dietro le nuvole bianche che si rincorrono nel cielo e si dissolvono tra mille forme in mille sogni. Come una brezza di vento primaverile una mano leggera gli aveva sfiorato i riccioli impiastricciati dalla terra e dal sudore, destandolo dalle sue fantasie che si volatilizzarono con un brivido negli occhi azzurri della Vale. Si era chinata come per raccogliere margherite in un prato e dal suo cappotto sbocciavano due malleoli scolpiti nella seta. I lunghi capelli neri ora cadevano morbidi sulle sue spalle e circondavano il suo volto apertosi in un audace sorriso. Mentre infilava le dita tra i capelli arruffati di Napo quasi volesse scovare un rifugio intimo, un suono tropicale si era distaccato dalle labbra della Vale provate dal freddo. «Sei stato il migliore.» Poi si era librata in aria come una farfalla per raggiungere le sue amiche che già avevano imbucato il porticato che conduceva al sagrato della chiesa.
«Andiamo, Napo.» Il braccio teso del Banana aspettava un cenno di vita, anche solo una palpitazione. Disteso ancora sul terreno di gioco e con la testa impigliata nella rete, Napo pareva la caricatura di un burattino di legno che non aveva alcuna intenzione di aprire le palpebre, forse per non far scappare quel sogno. Si era alzato barcollando come un pugile e adesso il braccio del Banana gli aveva avvolto le spalle non per proteggerlo, ma per condividere quel momento di smarrimento o magari per lasciare la sua immagine impressa nel ricordo di una nuova, grande avventura. Dietro di loro, Nonno Garella chiudeva il sipario di quella memorabile partita di pallone.
Abbracciati come solo due amici che giocano insieme a pallone sanno fare, il Banana e Napo avanzavano trionfali verso lo spogliatoio. Napo procedeva come un eroe al ritorno da una battaglia, a testa alta come se volesse raccogliere allori tra i tifosi che si erano attardati nelle ultime chiacchiere. Fino a quando, sulla soglia dello spogliatoio, aveva incrociato suo padre che era ancora lì, immobile nel suo paltò grigio e con gli occhi di ghiaccio che si scioglievano in un sorriso appena abbozzato sotto la coppola.
«Adesso filate tutti a casa,» aveva gridato il mister dopo i rituali baccanali nello spogliatoio. «Ci vediamo martedì prossimo alle cinque, vi aspetto.»
Alla spicciolata, tutta la squadra si era dispersa al “rompete le righe” di Nonno Garella, che reggeva sulle spalle il borsone del nipote. I primi a uscire dallo spogliatoio erano stati Pezzey e Mille Lire, che dopo aver abbracciato gli altri compagni avevano salutato militarmente l’allenatore, portandosi il palmo della mano destra sulla fronte. Mezzo Litro, il Banana e la Lecca li avevano seguiti a ruota, congedandosi con un’ostentata riverenza; Napo aveva tirato una pacca sulla spalla del portiere e prima di uscire aveva stretto la mano, come fanno le persone adulte, a Nonno Garella.
Fuori c’era il padre ad attenderlo. Mentre gli si avvicinava lentamente, trascinandosi sulla schiena il borsone, assaporava ogni istante di quel magico incontro. Senza dire una parola, il padre gli aveva preso la sacca dalle mani e aveva cominciato a camminare verso l’uscita dell’oratorio. Al suo fianco, Napo avvertiva una strana sensazione. Ad ogni passo l’imbarazzo di tornare a casa con il padre si alternava con la gioia della sua presenza e solo l’impressione di sentirsi più grande riusciva a dribblare la soggezione del suo giudizio.
«Una gran bella partita,» era stato il padre a ingrangere quel muro di inquietudine che spingeva avanti Napo e quelle parole bastarono a rompere gli argini della sua incontenibile felicità. «Non ci credo, hai visto tutta la partita?» esplose Napo con due occhi colmi di contentezza. «Quando sono arrivato, era iniziata da una decina di minuti,» disse in tono serafico. «Però ho fatto in tempo a vedere la traversa che hai preso dal corner e il rigore che hai sbagliato,» aggiunse nascondendo il rimbrotto in un dolce sorriso. «Sì, lo so, ma anche Gigi Riva sbaglia i rigori,» si difese Napo, mentre il padre si crogiolava in una sonora risata. Lo aveva stretto al suo fianco in un abbraccio maturo che mai prima di quel momento Napo riusciva a ricordare.
Napo era raggiante mentre stava per attraversare il cancello dell’oratorio. «Ciao don,» disse con l’allegria sulle labbra. «Buona giornata,» aggiunse non meno contento il padre, noto mangiapreti della zona e campione di tressette al bar della piazzetta. Don Antonio li guardava con la serenità del buon pastore che osserva le sue pecorelle. «Arrivederci a voi,» rispose placido mentre accarezzava la testa ancora bagnata di Napo.
Sul sagrato della chiesa, l’ultimo drappello di amici si scambiava saluti e promesse. C’erano la Lecca e il Banana insieme alle ragazze che avevano deciso di sfidare il ritardo e i rimproveri dei genitori. «Aspettami un secondo, torno subito,» e, senza attendere la risposta del padre, Napo si era già fiondato nel gruppetto di amici.
Suo padre, piantato lì in mezzo al sagrato, con il borsone sulla spalla assisteva con pazienza a quella scena da romanzo di borgata. Nel chiacchiericcio generale, Napo si era avvicinato alla Vale e le teneva le mani con tenerezza. Il padre non aveva alcuna intenzione di avvicinarsi a quel quadretto che, ai suoi occhi, sgocciolava fantasie adolescenziali un pochino mielose. Alla fine di quell’eterno idillio, Napo aveva preso il coraggio di petto e aveva accarezzato il volto della fanciulla che, in un palpito, aveva chinato il capo sulla sua mano, socchiudendo le palpebre.
«Chi è quella ragazza?» Stavano attraversando le rotaie del tram quando il padre, con tutta l’indifferenza di cui era capace, aveva lasciato cadere la domanda che Napo si attendeva da un momento all’altro. Che cosa può rispondere un bambino colto con le dita nella marmellata? Napo non era in grado di mettere insieme una risposta di senso compiuto che non suonasse come una banalità. Cercava rifugio nei suoi pensieri, ma il silenzio che accompagnava le sue lunghe falcate caricava d’attesa ogni metro che li separava dal portone di casa. «Vai che ho visto come ti guardava durante la partita o come ti gingillavi ogni volta che passavi vicino a lei.»
In quelle parole Napo non era riuscito a trovare la beffa o la derisione che poteva aspettarsi dal padre, piuttosto aveva colto una nota di complicità che amplificava ancora di più la sua voglia di sentirsi grande. «Un’amica,» era arrivato a balbettare alzando lo sguardo imbarazzato negli occhi grigi di suo padre, che adesso lo stringeva ancora più forte tra le braccia. «Vieni, andiamo. Ti ho preparato la parmigiana di melanzane.»
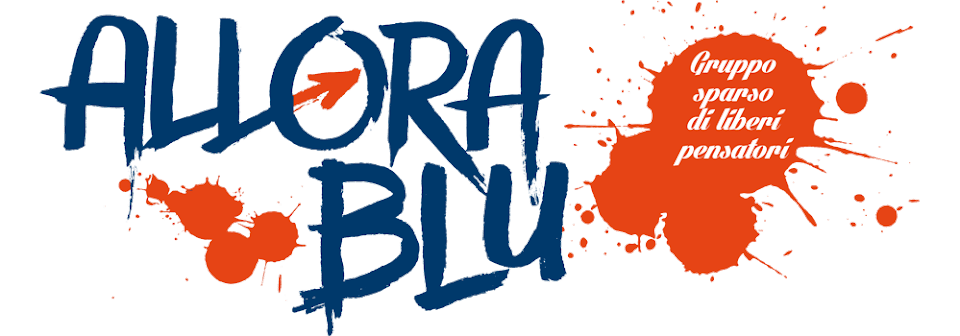
Nessun commento:
Posta un commento